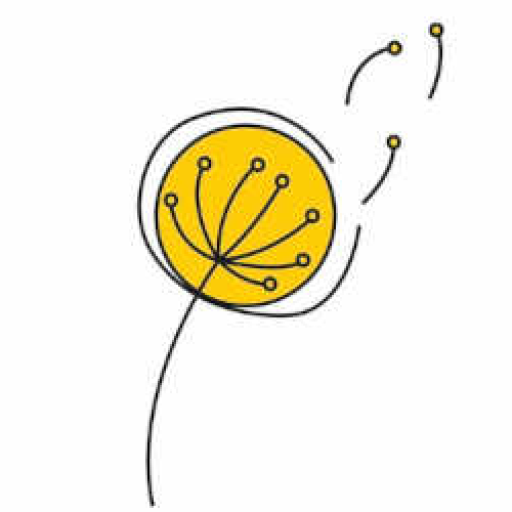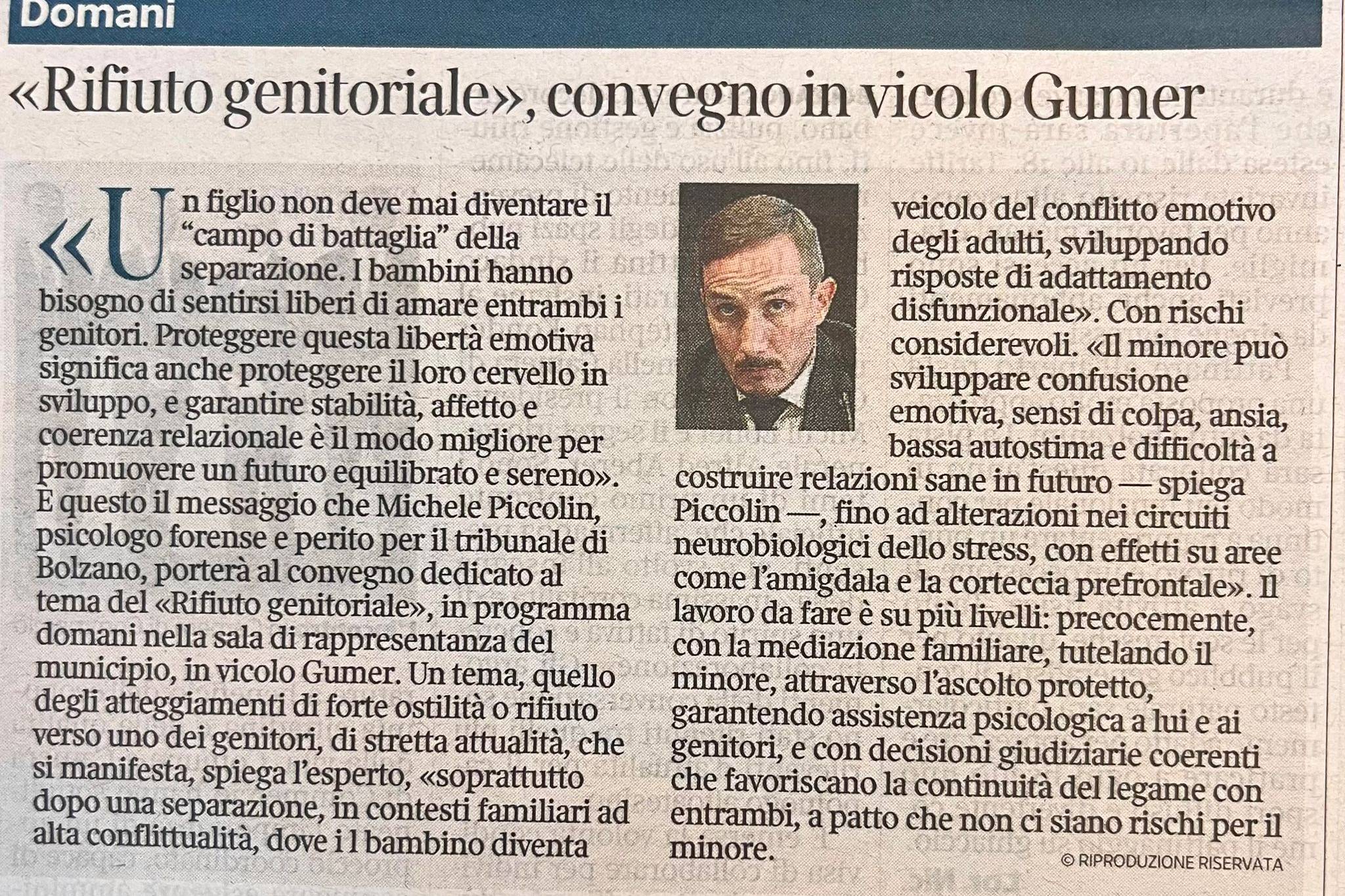“Doppio domicilio”, si parla di figli
Vezzetti: «Il tema è la genitorialità nelle coppie separate, e l’Europa è senza linee guida»
Domani dalle 14.30 nella sala di rappresentanza del Comune di Bolzano si terrà il convegno internazionale “Doppio Domicilio/Zwei Zuhause” dedicato al diritto dei bambini figli di separati a vedere e frequentare entrambi i genitori in modo equilibrato, continuativo e significativo. Alcuni tra i maggiori esperti europei metteranno a confronto le esperienze dei loro paesi. Tra i relatori principali del convegno Vittorio Vezzetti, pediatra di Varese e responsabile scientifico della piattaforma europea Colibrì, il Coordinamento Interassociativo LibereIniziative per la Bigenitorialità e le Ragioni dell’Infanzia, che riunisce numerose associazioni che da anni si battono per la tutela dei diritti dei minori. A lui abbiamo rivolto qualche domanda.
. Di cosa parlerà a Bolzano?
«Ho appena presentato presso il Parlamento europeo in Strasburgo la prima ricerca comparata sull’affido dei minori in Europa. Malgrado tutti gli Stati affermino di muoversi nel supremo interesse del minore, questo viene interpretato in maniera diversissima da Stato a Stato. Questo sarà uno dei punti del mio intervento».
Questo significa, per esempio, che i minori greci o italiani sono trattati in modo diverso da quelli svedesi o belgi?
«Proprio così. In questo senso sto operando per chiedere che la Commissione Europea affronti il problema da un punto di vista scientifico prima che giuridico, individuando delle best practices, delle linee guida: se la mia istanza -abbastanza rivoluzionaria- dovesse essere accolta dai politici, muterà il destino di milioni di minori europei: oltre dieci milioni sono i figli di coppie separate in Europa».
Quali sono le cause principali di perdita di contatto tra genitori e bambini in Europa?
«Come in tutti i Paesi industrializzati e non attraversati da guerre è la separazione della coppia genitoriale».
Sono state fatte delle ricerche scientifiche sulle conseguenze della separazione familiare sui bambini?
«Assolutamente sì. Nel mio intervento documenterò con gli studi più recenti a livello mondiale le ricadute dirette e indirette in termini di benessere psico-fisico delle varie forme di affidamento».
Si tratta quindi principalmente di un problematiche inerenti alla salute dei bambini europei?
«Direi che proprio questo è il punto. Ormai siamo riusciti ad avere prova del danno organico causato dalla monogenitorialità e dagli stati persistenti di sofferenza psicologica. Per questo la disomogeneità europea in termini di affidamento dei minori mi fa domandare se non si tratti piuttosto di un’applicazione non omogenea del Diritto alla Salute dei nostri figli. Tema su cui l’Europa ha ampie competenze».
Lei si propone di inquadrare il problema dell’affido da un punto di vista scientifico, prima che giuridico. Cosa propone la scienza per migliorare la situazione?
«Devono essere instaurate delle linee guida, sempre adattabili al caso concreto ma ben diverse dalle abitudini giurisprudenziali della maggior parte dei Paesi. Ormai, con molta lentezza, si sta affermando l’importanza della condivisione delle cure e questo si rispecchia in quella che internazionalmente si chiama “shared custody” o physical joint custody”: l’affido materialmente condiviso che è cosa completamente diversa dall’affido legalmente condiviso che abbiamo oggi in Italia e che in nessun paese al mondo è servito a promuovere una concreta bigenitorialità».
Qual è la situazione in Europa? E quale in Italia?
«Abbiamo un’ Europa a tre velocità: in testa la Scandinavia e il Belgio, in mezzo la Francia e poi la Spagna e la Germania, in fondo ci siamo noi italiani assieme ad altri paesi tra cui la Svizzera, il Portogallo, la Grecia e l’Austria. La bigenitorialità è un concetto affermato nei paesi dotati del maggior welfare, mentre in generale vi è una scarsa considerazione della genitorialità maschile: l’Italia si distingue avendo il minor tasso mondiale di affido al padre con lo 0,8%.(per fare dei raffronti l’affido al padre riguarda la Francia nel 7%, Germania 13% , la Svizzera nel 3,77%, la Spagna si attesta al 5,3%, la Slovacchia al 9,36%
Barbara Gambino
Corriere dell’Alto Adige